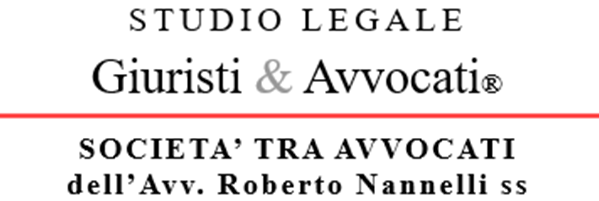Cass. Sez. I, 10.2.2022 n. 4347
Diritto societario – società di capitali – amministratori – responsabilità – danno – quantificazione – criteri
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore di fallimento ai sensi dell’art. 146, secondo comma, I.fall. contro l’ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l’avvenuta riduzione, per perdite, del capitale sociale al disotto del minimo legale, il giudice, ove, nella quantificazione del danno risarcibile, si avvalga, ricorrendone le condizioni, del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, temperato dalla espunzione da tale differenza del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società, deve indicare le ragioni per le quali, da un lato, l’insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell’amministratore e, dall’altro, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall’insufficienza delle scritture contabili sociali; e ciò sempre che il ricorso a tale criterio equitativo sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.